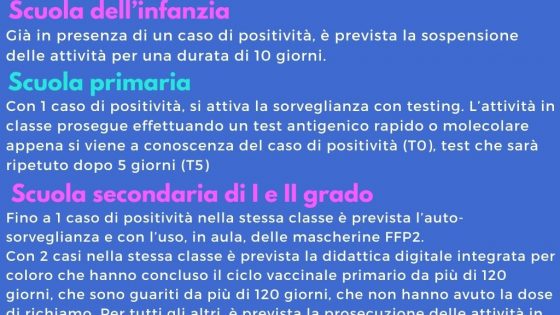Ci occuperemo, in questo articolo, nuovamente dei rischi legati alla diffusione di materiale foto e video, le cui ragioni e risultati sono molto diverse da quelle inerenti all’ultimo argomento trattato, la pedofilia.
Si tratta, in questo caso, di un fenomeno poco conosciuto e spesso sottovalutato, il “revenge porn”, una pratica d’odio che viene attuata attraverso la diffusione non consensuale in gruppi social, ma anche su altri siti, di scatti o video intimi.
In Italia le vittime di questo fenomeno sono 2 milioni, per il 70% donne, che spesso scoprono della diffusione di questi contenuti in autonomia o su segnalazione da parte di conoscenti o anche di persone sconosciute.
Tre anni fa è stata approvata la Legge Codice Rosso, un disegno di legge che ha ridotto i tempi di indagine e inasprito le pene per i crimini quali stalking, revenge porn e sfregio al volto.
Nonostante ciò, questa pratica d’odio non è considerata alla stregua degli altri crimini e, come dicevamo, spesso sottovalutata. Silvia Semenzin, coautrice del libro “Donne tutte puttane: Revenge porn e maschilità egemone” ha spiegato perché ciò accade: “Il fatto che ci si sia focalizzati sull’idea della vendetta (“revenge” appunto) ha portato a prevedere il dolo specifico. La vittima deve procurarsi le prove, magari persino entrando nei gruppi dove è avvenuto il reato e deve dimostrare che il suo carnefice volesse farle del male.

Purtroppo, però, sappiamo che in molti casi l’elemento della vendetta non c’è e spesso nemmeno l’intenzione specifica di danneggiare la persona. Piuttosto il problema è il potere sui corpi femminili normalizzato come forma di ‘goliardia’ tanto che si finisce per condividere con leggerezza le immagini intime altrui”.
La difficoltà incontrata nel dover dimostrare di essere effettivamente una vittima per sentirsi in diritto di essere aiutata, crea un sentimento di sfiducia nei confronti delle forze dell’ordine, si è restii quindi a denunciare per evitare di dover subire una maggiore umiliazione.
Un altro fattore che rende la legge incompleta, è la mancanza dell’elemento “violenza di gruppo”. Viene considerato soltanto il rapporto tra due persone, in cui un carnefice si vendica sulla vittima, probabilmente per essere stato lasciato. Non viene presa in considerazione la moltitudine di altre persone che contribuiscono alla diffusione dei contenuti intimi e le piattaforme che lo rendono possibile.
Nonostante quindi si tratti di uno dei temi maggiormente preoccupanti nella sfera della sicurezza informatica, l’84% di coloro che condividono materiali intimi senza consenso, afferma che non avrebbe problemi a rifarlo, poiché non lo identifica come un reato, ma come un atto di goliardia, oppure si giustifica affermando di non essere a conoscenza della NON consensualità da parte della vittima.

Le ripercussioni psicologiche e sociali, evidenziate dalla persona danneggiata, sono molto gravi. Innanzitutto c’è il problema della fiducia tradita, poiché in gran parte dei casi, la ricondivisione non consensuale avviene in seguito alla condivisione degli stessi materiali con qualcuno di cui si aveva fiducia.
La colpevolizzazione della vittima, sia da parte della stessa che dell’opinione pubblica, peggiora la situazione. Quando si tratta di crimini come il revenge porn, infatti, si tende a considerare la persona tradita come carnefice di se stessa, poiché il problema comunemente riconosciuto non è che i materiali siano stati condivisi senza consenso, ma il fatto che li abbia volontariamente prodotti. Si tratta della diffusa tendenza a colpevolizzare la vittima, soprattutto se donna, sempre meno padrona del proprio corpo.
Esistono storie tragiche, più o meno conosciute, di persone licenziate, allontanate dalla propria famiglia o che, ancor più, hanno scelto il suicidio come via di scampo dalla stigmatizzazione e dall’impotenza di mettere fine alle proprie sofferenze.