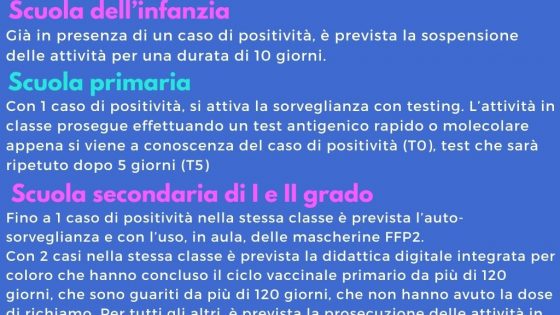“Chi ha vissuto più volte deve morire più volte”.
Quanto può essere difficile vivere sospesi: tra sogno e realtà; tra poesia e follia. Un limbo esistenziale che Alda Merini ha conosciuto molto bene, tanto da immagazzinare vizi e virtù dell’esistenza in una sorta di vocabolario per le percezioni umane, dove la passione diventa riflessione, leggerezza ed empatia. Così appare oggi, proprio come in quel “meriggiare placido” del primo novembre del 2009, quando la poetessa del Naviglio lasciava questa vita; un corpo robusto, ma sensibilmente fragile, quanto la “forte” delicatezza di un cristallo che vacilla su un tavolo senza una gamba.
Raramente in Italia si parla di un poeta, come si è fatto per Alda Merini: forse perché la sua vicenda umana è riuscita a smuovere coscienze trasversali; o forse perché la lucidità vibrante che usciva dalla sua penna era così curiosa, verso tutto ciò che rappresenta il moto dell’anima, da trasmettere una costante e irriverente serenità, pur nel tentativo di dissoluzione della dignità, cui la scrittrice fu evangelicamente legata.La poesia è riflessione, empatia, pensiero e tutto ciò che non appartiene alla dimensione del tempo, ma per Alda Merini la poesia ha sempre rappresentato un modo per recuperare tempo. Nel momento in cui il ritmo della quotidianità ci rende frettolosi, esiste una cura per aiutare l’uomo moderno a conquistare l’autonomia del suo tempo.
È possibile aggiungere come il linguaggio, la forza interiore e la caparbietà rilevante della poetessa milanese fossero state un rimedio per prendersi cura del proprio tempo: quell’insieme d’istanti che misero la poetessa davanti all’incompatibilità del suo essere, rispetto a una società troppo terrorizzata dalla curiosità, costringendo quel corpo a una vita da recluso, abbandonato, bollato come non conforme alla società delle contraddizioni, che si stava facendo largo nell’Italia del Boom economico.

La stanza di Alda Merini
Alda Merini ha lottato tutta la vita, come tanti altri artisti prima di lei, il pregiudizio e l’isolamento: Milano e il suo Naviglio Grande, nell’ebbrezza futurista data dal bisogno di “bere” il succo della vita moderna, si accorsero di lei un po’ troppo tardi. Eppure Alda ha sempre amato la sua città e i canali che vedeva dal suo monolocale; ella amava quel senso di irrequieta contemplazione dei suoi elementi, dai suoni del mercato al rumore dell’acqua nei tombini, di fronte alla quale l’uomo resta attonito, in attesa di sapere o, ripartire; anche questo era per lei, la città e lei vegliava su di essa come una “nonna” metropolitana, come se mai niente fosse accaduto; dal giorno in cui il suo sguardo di bambina incontra Cesare Pavese, a quello in cui un infermiere le metterà la camicia di forza. A distanza di dieci anni, quella Milano non è cambiata molto; Il ponte sul Naviglio Grande, che lei attraversava, è stato dedicato alla sua memoria, oltre a una casa, in via Magolfa, che riproduce fedelmente il luogo in cui ha vissuto. Ciò che rimane di Alda Merini è il fuoco sacro delle sue parole, una sfrontata saggezza travestita da ribellione e soprattutto una memoria limpida e vivace, capace di fotografare luoghi, volti, urla e amori, come fosse l’istantanea di un momento di cultura popolare profondo e reale; talmente crudo e potente da poter leggere l’intera commedia umana, irta di pensieri vorticosi; “dove le mille allegrie muoiono piangenti sul Naviglio.”
ISCRIVITI
ALLA NOSTRA NEWSLETTER